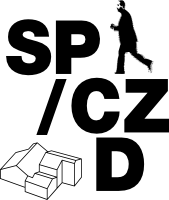Sali.
Ce la puoi fare.
Non pensare, agisci.
Ancora un ultimo sforzo.

White Out di Piergiorgio Milano ph. Andrea Macchia
Herve Bermasse è un alpinista italiano, ultimo discendente di una dinastia di “montanari” professionisti. Ha fatto della montagna la sua vita, dopo essersene perdutamente innamorato a seguito della sua prima scalata da professionista nel Cervino nel 2000.
Ottomila metri sono stati la sfida che nel 2017 ha tentato, accompagnato dal tedesco David Gottler: la scalata impossibile dello Shisha Pangma in Tibet. Partiti insieme dalla valle del monte nelle prime ore del mattino, i due sono riusciti ad arrivare a tre metri dalla vetta, per poi scendere in circa tredici ore, compiendo un record fino a quel momento impensabile. Bermasse e Gottler hanno scritto una nuova pagina di storia dell’alpinismo che, nonostante tutto, ha un sapore leggermente amaro a causa di quei pochi passi che li hanno separati dalla vetta.
«Ci siamo detti “fermiamoci qui”. A ogni passo il manto nevoso su cui procedevamo era tutto uno scricchiolio. Rumori profondi di assestamento. Pochi passi che indicano vita o morte, a seconda della decisione. Parrebbe inutile sottolinearlo per molti, ma noi vogliamo dirlo, ci siamo fermati a 2 o 3 metri dalla vetta per poter tornare giù, per vivere». (La Stampa, 2017)
È un realismo conscio quello dell’alpinista. Consapevole dei possibili rischi, ha scelto di sopravvivere.
«Quando sei a casa e ti alleni per realizzare un sogno è molto facile. È quando il sogno ti si presenta alto più di duemila metri sopra di te e parti per realizzarlo con 25 metri di corda e poco materiale che pensi sia irrealizzabile».
«E così ammetto di aver avuto paura di non essere in grado di realizzare il sogno. Sovrastato dalla grande montagna mi sentivo piccolo, piccolo. Poi il primo passo, quindi un altro, la testa si svuota dai pensieri pesanti e inizi a salire. Ma finita la parete, quando siamo arrivati sul plateau finale che porta alle gobbe e alla cresta di vetta e sprofondavamo fino al ginocchio, le nostre chance erano pochissime. E i dubbi sono tornati. Eravamo soli su tutta la montagna che si presentava in modo differente, cambiata per il terremoto di tre anni fa. E da allora non è stata più salita».

Foto tratta dall’intervista a cura di Planet Mountain su scarpa.com
La ricerca della vetta può diventare una vera e propria dipendenza, un pensiero fisso che porta ad assumersi rischi spesso non calcolabili a causa, ad esempio, delle condizioni meteo facilmente mutabili. Così, l’alpinista rischia la vita per qualcosa di apparentemente inutile, ma lo fa perché altrimenti non avrebbe senso vivere. Certamente prendere una decisione sbagliata in quel contesto (come avviene in similitudine anche nella vita) potrebbe innescare una serie di eventi nefasti, un “effetto farfalla” capace di portare nei casi più estremi anche alla morte.
Pensiamo a Battista Bonali, ritenuto da molti l’alpinista italiano più celebre degli anni Ottanta e Novanta. Nel 1993 perse la vita sulla parete nord dell’Huascaràn, a duecento metri dalla vetta, travolto da una scarica di ghiaccio e rocce, mentre insieme all’amico Giandomenico Ducoli cercava di ripercorrere la via Casarotto. Ai due è stato dedicato un rifugio, in omaggio alle imprese da loro compiute, che è divenuto per gli alpinisti simbolo di coraggio e amicizia.


Rifugio Torsoleto
Battistino Bonali e Giandomenico Ducoli foto di G.Cemmi
I due alpinisti erano legati da una fortissima amicizia nutrita da profondi sentimenti di rispetto ed empatia coltivati anche grazie alla condivisione di esperienze – come possiamo immaginare – estremamente forti. In situazioni d’emergenza la paura della morte rende completamente nudi. Forse è anche questo aspetto di sfida che appassiona chi pratica l’alpinismo. Guardare in faccia la morte e sbeffeggiarla, rimanendo consapevoli che ogni momento potrebbe essere l’ultimo anche soltanto per un piccolo passo errato.
Con queste parole viene ricordato Bonali:
«Grazie montagna per avermi dato lezioni di vita, perché faticando ho appreso a gustare il riposo, perché sudando ho imparato ad apprezzare un sorso d’acqua fresca, perché stanco mi sono fermato e ho potuto ammirare la meraviglia di un fiore, la libertà di un volo d’uccello, respirare il profumo della semplicità, perché solo immerso nel tuo silenzio, mi sono visto allo specchio e spaventato ho ammesso il mio bisogno di verità e amore, perché soffrendo ho assaporato la gioia della vetta percependo che le cose vere, quelle che portano alla felicità, si ottengono solo con la fatica. E chi non sa soffrire, mai potrà capire». O. Forno, Battistino Bonali: grazie montagna, Cuneo, Mountain Promotion, 2003.

White Out di Piergiorgio Milano ph. Andrea Macchia
Nello spettacolo White Out affiora questo concetto di forte amicizia. Soprattutto all’inizio quando un alpinista-performer trascina ostinatamente con sé anche i corpi dei due amici ormai defunti, nonostante le sue evidenti difficoltà. La presa di cura dell’altro non esiste solo nell’amicizia ma può essere un tratto distintivo generale di una persona. Secondo l’antropologa Margaret Mead la nascita della civiltà è ravvisabile in quel momento in cui i membri di una comunità iniziano a prendersi cura l’uno dell’altro.
Mingma Gelje, il più giovane ad aver scalato il K2 in inverno, ne è una dimostrazione. Aveva iniziato a scalare le montagne per passione, per poi diventare uno scalatore professionista oltre che una guida alpina. Il suo nome ormai, nel mondo dell’alpinismo in particolare, viene molto ricordato per le sue varie imprese di soccorso.
Ma più che per i suoi soccorsi “all’ordine del giorno” vi è stato un salvataggio in particolare che ha richiamato anche l’attenzione del New York Times.


La vicenda, avvenuta un anno fa, riguarda il salvataggio di un uomo che si trovava nella “Zona della morte” sull’Everest. L’impresa venne definita un “miracolo” persino dai funzionari del Dipartimento del Turismo, perché è quasi impossibile essere salvati in quella zona.
Gelje, nonostante non conoscesse quell’uomo, è stato disposto a trasportarlo sulle sue spalle per più di sei ore, caricandosi – tra peso effettivo del corpo, vestiti e attrezzatura dell’uomo – più di cento chili. Alternandosi ogni tre ore con un suo compagno, insieme non lo lasciarono indietro. Non lo lasciarono morire. Erano quasi giunti alla vetta, ma sono tornati giù per aiutare.
Se ci soffermiamo a pensarci non è per niente scontato. E infatti, come ha dichiarato è stata l’impresa più difficile mai compiuta.
Purtroppo, la montagna non è un gioco e per fortuna nella maggior parte dei casi fra gli alpinisti vi è molta coesione. Ma è un attimo, un passo sbagliato, un cambiamento climatico, una perdita di equilibrio… ed ecco che
“Sali”
“Ce la puoi fare”
“Non pensare, agisci”
“Ancora un ultimo sforzo”
Si trasformano in..
“Non sono riuscito a salvarlo”.
Dopo la visione dello spettacolo White out di Piergiorgio Milano ci siamo trovati a riflettere su quali pensieri potessero passare per la mente di un uomo disperso nell’immensità di un monte innevato. Solo, infreddolito, tremante e privo di ogni speranza di sopravvivere. Chiunque avrebbe pensato di arrendersi e abbracciare la morte.
La verità però, pensiamo, sia che nei momenti più bui l’essere umano si tramuti e anche se ormai disilluso rispetto alla vita, cerchi disperatamente di aggrapparsene assaporando ogni istante come fosse l’ultimo, e così forse riesce a sopravvivere.
Di:
Donato Gabriele Cassone
Laura Raneri
Questo articolo fa parte della rubrica: