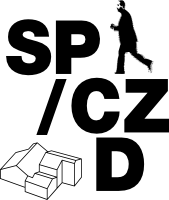Soffrire rende davvero le persone più forti?
Cosa significa essere forti?
Quali sono le ripercussioni di una convivenza con il dolore?
Sprofondare nella solitudine è possibile?
Ciò che rende più forti è, forse, il perdono?
Accettare noi stessi è la chiave per il perdono e una vita tranquilla?

–
Nell’Agamennone (criminal case) di Salvatore Romania e Laura Odierna emerge il bisogno di raccontare un parallelismo tra mito e realtà. Nella vita di tutti i giorni così come nel mito di Eschilo, il dolore, la sofferenza, l’aggressività e soprattutto la «banalità del male» possono esprimersi in modi e contesti incredibilmente variegati. Spesso a svilupparsi è una catena per cui «a parola di odio risponde parola di odio e per sangue sparso si spande altro sangue».
Agamennone, totalmente conscio di ciò che stava per compiere, spezza la vita della figlia, sacrificandola in cerca di venti migliori, come consigliato dall’indovino Calcante. Clitemnestra però, non potendo sopportare ciò che aveva compiuto il marito, decide di ucciderlo, bagnandosi le mani di altro sangue e, dal canto suo, macchiandosi di peccato in quella che, all’epoca, era una società in cui vigeva la “cultura della vergogna”. Il destino però, si può vedere solo proiettandosi nel futuro e in questo caso la sorte non sarà caritatevole con la donna, ormai vedova e senza una figlia, in quanto il figlio, Oreste, la ucciderà, a sua volta, per vendicarsi dell’omicidio del padre. Ad interrompere questo “filo rosso”, colorato dal sangue di tutti gli omicidi, sarà la politica che riuscirà a troncare questa catena, salvando Oreste.
L’esperienza tragica che vivono tutti i personaggi può essere considerata come processo di interiorizzazione della conoscenza, un processo autentico di maturazione psicologica e caratteriale, portato avanti dal dolore e dalla sofferenza che lega tutti indissolubilmente.

–
«Soffrire per comprendere, comprendere soffrendo»
Eschilo
Il dolore che spesso si insidia nelle fessure più strette della vita degli uomini e delle donne è molte volte considerato come un’arma a doppio taglio che, però, se si riuscisse a controllare, potrebbe portare un futuro caratterizzato da una consapevolezza intrinseca di saggezza e resilienza; quasi come un dono che si è conquistato con il duro lavoro. Quando capita di vedere una persona soffrire, per i più svariati motivi, la prima reazione istintiva che le persone hanno è pensare: “mi dispiace per lui”. In realtà, di solito, questa risposta non emerge tramite un processo mentale “conscio”, bensì, quasi per riflesso, “inconscio”.
«Ogni cosa che vogliamo, ogni cosa di cui abbiamo paura, ogni cosa che alla fine decidiamo di fare, è perché in realtà, a conti fatti, noi desideriamo l’amore, vorremmo avere più tempo e temiamo la morte».
Collateral beauty (2016)
La risposta sociale che manifestiamo quando ci approcciamo al dolore e alla sofferenza, non deriva, di solito, dal fatto che ci caliamo nei panni dell’altro, ma dalla paura che insorge in noi bollente, fremente e pervasiva. Temiamo, insomma, che ciò che è successo a chi abbiamo davanti possa succedere a noi e quasi per uso socialmente accettato, tramite un processo involontario, cerchiamo di farci scivolare addosso, senza che si attacchi a noi, nemmeno fosse un virus mortale, il dolore. Empatizzare con le persone è difficile, bisognerebbe avere una grande “intelligenza emotiva”, una capacità intrinseca dell’essere umano di porsi nei panni dell’altro cercando di comprendere, senza aprire il cervello dell’altro a metà, cosa gli passi per la mente.
L’intelligenza emotiva, teorizzata da Daniel Goleman, discende da una serie di studi neuropsicologici di cui il promotore negli anni Novanta fu Giacomo Rizzolatti. Neuroscienziato italiano, egli pensava che nell’uomo e anche in alcuni animali, come ad esempio le scimmie, fossero presenti dei neuroni che denominò “specchio” in grado di attivarsi anche quando l’azione non fosse compiuta da noi stessi ma dagli altri e, addirittura, di attivarsi anche pensando ad una determinata azione senza compierla.
Nei giorni che corrono, forse, alcuni uomini hanno “deciso” di dimenticare di possedere questi neuroni, li hanno imprigionati in un angolo del cervello piccolo, piccolo, probabilmente per paura. Terrore di non sopportare il dolore, timore di non essere in grado di fare nulla per gli altri e per sé stessi, agonia di non essere all’altezza. Bisognerebbe liberare questi poveri neuroni e abbracciare di nuovo l’empatia, in una danza d’amore che dovrebbe durare per sempre diffondendo gioia e amore.
Purtroppo, considerando ciò che ci circonda, questa è una visione del tutto utopistica.

–
«L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, l’importante è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare da essa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza» .
Giovanni Falcone
Essere forti, quindi, non significa non avere paura. Non significa essere indifferenti verso il dolore. Non significa mostrarsi ineluttabili agli occhi degli altri, creandosi un’armatura di carta pesta che, per distruggersi, necessita soltanto di poche lacrime. Essere forti significa prendere coscienza di chi siamo, sapere che non siamo perfetti, conoscersi profondamente, anche nelle più insite sfaccettature e, in definitiva, accettarci. Accoglierci per ciò che siamo, nelle nostre debolezze, nelle nostre paure e nei nostri fallimenti. Comprendere che, in primis, a giudicarci ogni giorno, se vogliamo, dobbiamo essere noi stessi, cercando, al contempo, di non essere troppo cattivi.
Nell’arco della nostra esistenza il giudizio, verso noi stessi o verso gli altri, molto spesso è fine a sé stesso. Sarebbe opportuno, invece, valutare gli effetti delle nostre azioni e usare gli errori per imparare da quelle cadute, arricchendo il proprio vissuto di consapevolezza. Bisogna perdonare sé stessi per non vivere ogni giorno con il dolore, un male che prima o poi, ci renderà più rigidi, freddi, meschini, indifferenti alle sofferenze altrui. Il perdono, in qualunque forma, serve prima di tutto a noi stessi e successivamente agli altri. Per non sprofondare nella solitudine bisogna saper fare i conti con questo agire, con questo sentimento, cioè il perdono. Non si può essere perfetti, ammesso che la perfezione esista.
Amare non significa camminare all’ombra di qualcuno, ma stare insieme e condividere quell’ombra.
Solo così si potrà arrivare ad essere sereni.

–
Alla fine del film Shutter Island (2010), il personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio diceva: «bisogna decidere: che cosa sarebbe peggio? Vivere da mostro? O morire da uomo per bene?». Interrogativo non semplice, a cui nemmeno i personaggi sanno dare una risposta. Nel film Il Cavaliere Oscuro (2008)di Nolan si può trovare una parziale risposta che recita: «o muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo».
Dunque, è questo il destino che spetta a qualunque uomo o donna. Scegliere, lungo tutto l’arco della vita, chi si vuole essere, anche se non sempre i confini sono così netti e definiti come si potrebbe credere.
F. Dostoevskij, Ricordi del sottosuolo.
«Io sono convinto che l’uomo non rinuncerà mai alla vera, autentica sofferenza… Giacché la sofferenza è la vera origine della coscienza… In realtà io continuo a pormi una domanda oziosa: che cos’è meglio, una felicità da quattro soldi o delle sublimi sofferenze? Dite su, che cos’è meglio?».
di Donato Gabriele Cassone
Questo articolo fa parte della rubrica: